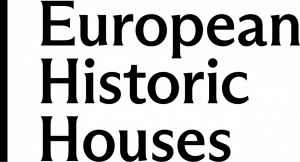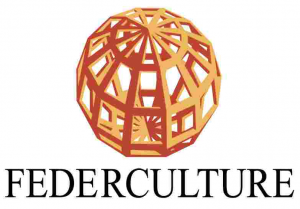- Toscana
year 2021

Dal 23-05-2021
Descrizione
visita al cortile e al giardino ORE 17:00 concerto a cura della Scuola di Musica di Fiesole
Dimora
L’origine del palazzo risale ai due noti architetti Giuliano (1445-1516) e Antonio da Sangallo (1455-1534), che possedevano diverse case nella zona acquistate in parte nel 1490 dai monaci cistercensi. Nel 1498 commissionarono la costruzione del nuovo palazzo, un edificio di pianta pressoché quadrata, con annesso un ampio orto, la cui lunghezza era circa il doppio di quello attuale. Lo storico Giorgio Vasari racconta di come in questo palazzo i due fratelli “condussero in Fiorenza nelle lor case una infinità di cose antiche di marmo bellissime …”, facendo del palazzo una sorta di museo personale, pari a quelli dei potenti signori che servirono nella loro vita; vi figuravano statue antiche e moderne, dipinti di celebri artisti quali Sandro Botticelli, Paolo Uccello e Antonio del Pollaiolo. Il complesso rimase di proprietà dei Sangallo fino al 1603 quando Jacopo e Giovanni vendettero la dimora con il giardino a Sebastiano di Tommaso Ximenes d’Aragona (1568-1633). Gli Ximenes d’Aragona, intraprendenti ebrei di origine portoghese che avevano accumulato una cospicua fortuna tramite i commerci con le Americhe, si erano trasferiti a Firenze nella seconda metà del Cinquecento. A seguito di ingenti investimenti nel Granducato di Toscana, Sebastiano ricevette in dono dal Granduca Ferdinando I dei Medici il feudo di Saturnia con titolo marchionale, coprì diverse cariche pubbliche, tra le quali quella di senatore nel 1625, e, nel 1593, sposò Caterina, figlia di Raffaello de’ Medici, marchese di Castellina. Sebastiano Ximenes, oltre a risistemare il giardino, incaricò un artefice di grido, l’architetto Gherardo Silvani, di rimodernare il palazzo, ingrandirlo verso sud e dotarlo di una nuova facciata caratterizzata, al piano terra, da un portale centrale affiancato da due coppie di finestre inginocchiate, e, al primo piano, da finestre trabeate laterali e un terrazzo centrale, sul quale si apre una porta-finestra sormontata dallo stemma di famiglia. Dopo l’intervento del Silvani il palazzo ed il giardino non subirono variazioni di rilievo, salvo abbellimenti e decorazioni dell’atrio e delle sale al piano nobile, incluso il rinomato salone da ballo, fino a poco dopo la metà del Settecento, quando Ferdinando Ximenes, nato nel 1747 e rimasto presto orfano del padre Anton Francesco, avendo ereditato l’immenso patrimonio familiare direttamente dal nonno nel 1753, ampliò l’edificio verso lo spazio verde retrostante. La nuova fabbrica articolata intorno ad un ampio cortile rettangolare preceduto da un grande androne, si affaccia sul giardino con un loggiato al piano terra, coronato da una serliana. Furono realizzate le due belle scale simmetriche a fasce curvilinee degradanti che si fronteggiano nel grande atrio di accesso. Il centro del cortile fu decorato da una statua di Ercole che lotta contro il leone, attribuita dall’architetto Francesca Screti allo scultore carrarese Giovanni Baratta, nato nel 1660 e allievo di Giovan Battista Foggini, e ai lati da due statue in marmo rappresentanti Apollo e Diana Cacciatrice. L’ampliamento promosso da Ferdinando comportò conseguentemente una riduzione del giardino che, probabilmente, venne sistemato in base alle nuove esigenze funzionali ed estetiche. Lo spazio verde fu suddiviso in aiuole di forma rettangolare allungata e coronato, sulla testata, da una fontana con “prospetto” che fungeva da quinta scenica all’ingresso del palazzo, seguendo il tradizionale schema del giardino urbano fiorentino. Nel 1775, in seguito alla soppressione delle corporazioni religiose attuata dai Lorena, gli Ximenes ingrandirono la proprietà, acquistando il contiguo noviziato di San Salvatore. Il noviziato era stato fondato nel 1632 dai Padri Gesuiti di San Giovannino, i quali avevano ricevuto in eredità il grande complesso dal Cavaliere Benedetto Biffoli, con l’obbligo di istituirvi un noviziato. Ferdinando, che era malauguratamente affetto da squilibrio mentale fin da giovanissimo, viaggiò spesso all’estero, e fu proprio in occasione di un soggiorno a Parigi che gli fu fatta sposare per procura la sedicenne Charlotte de Lesteyre, figlia di Gian Carlo, marchese di Saillant e conte di Combour, gentiluomo di camera del re di Francia Luigi XVI. La giovane era anche nipote per parte di madre del conte di Mirabeau, alle prese con debiti di gioco. La famiglia de Lesteyre riuscì ad entrare nell’amministrazione dei beni del marchese, grazie anche all’aiuto del chirurgo personale di Ferdinando, Giovanni Utis, che era riuscito a far nominare suo fratello Antonio amministratore per conto dei de Lesteyre dell’intero patrimonio familiare Ximenes d’Aragona. I legami tra i de Lesteyre e i rivoluzionari sono testimoniati anche dal fatto che nel 1796 l’ambasciata francese a Firenze fu trasferita proprio nel palazzo Ximenes di Borgo Pinti; qui fu poi ospitato Napoleone nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio 1796, in occasione della sua visita a Firenze, e qui pure si insediò nei primi giorni di aprile del 1799 (dopo la fuga del Granduca) il Ministro Residente della Repubblica Francese, il cittadino Reinard. Alla morte del marchese Ferdinando, ultimo discendente maschio della famiglia Ximenes, il palazzo e il giardino passarono nel 1816 ai figli Bandino (1764-1821) e Pietro Leopoldo (1766-1818) della sorella di Ferdinando, Vittoria, che si era sposata con Niccolò Panciatichi, esponente di un’importante famiglia pistoiese trasferitasi a Firenze nel XVII secolo. I nuovi proprietari, che avevano assunto il cognome Panciatichi Ximenes, ristrutturarono il noviziato di San Salvatore e lo integrarono al palazzo, in modo da creare un’unica unità immobiliare. I lavori, eseguiti tra il 1839 e il 1840, furono progettati dall’architetto Niccolò Matas che tuttavia conservò nel giardino l’originario impianto all’italiana. Nella seconda metà dell’Ottocento, il complesso fu ridotto con la costruzione del quartiere della Mattonaia e il conseguente prolungamento di via del Mandorlo, oggi via Giusti, fino a piazza d’Azeglio: la proprietà Panciatichi Ximenes fu così tagliata in due e fu distrutto l’antico giardino dei Gesuiti conservatisi fino ad allora. Dopo i tagli dovuti al prolungamento della strada di via del Mandorlo, nella seconda metà del XIX secolo, Marianna Panciatichi, ultima discendente della famiglia, sposata ad Alessandro Anafesto Paolucci delle Roncole, donna colta e studiosa di scienze naturali, fece ampliare e restaurare il palazzo, con l’aggiunta di un nuovo fronte verso mezzogiorno, e fece trasformare il giardino in un parco romantico secondo una configurazione che ancora oggi lo caratterizza. Spiccati elementi ottocenteschi nel giardino sono la grande aiuola centrale e i vialetti di ghiaia che le girano attorno e che permettono di avere visuali diverse del palazzo. Estintisi i Panciatichi con la morte di Marianna, sempre per mancanza di eredi maschi e quindi per linea femminile, il palazzo passò prima ai Rabitti-San Giorgio, poi da questi alla famiglia padovana degli Arrigoni Degli Oddi, l’ultima dei quali, Oddina, andò sposa a Francesco Ruffo di Calabria, principe di Scilla, e successivamente alla figlia e attuale proprietaria, Isabella Fabrizia Ruffo di Calabria Becherucci, moglie del compianto Cavaliere del Lavoro Ing. Raffaele Becherucci, imprenditore industriale con la passione per il restauro. Dopo le ultime manomissioni avvenute nel 1934, quando il Conte di San Giorgio, allora proprietario dell’immobile, vendette una parte dell’antico giardino lungo via Giusti per costruirvi un edificio con più appartamenti, il palazzo soffrì gravi danni durante l’alluvione dell’Arno del 4 novembre 1966, che provocò la distruzione di tutti gli arredi laccati veneziani che adornavano il piano terreno. Nel corso del 2001/2002, in occasione di un matrimonio di famiglia dell’attuale proprietaria, e successivamente nel triennio 2005/2007, tutto il piano nobile del palazzo, compreso lo scalone di onore, è stato oggetto di un attento lavoro di restauro ad opera dell’Ing. Becherucci, che ha permesso il ritorno del salone da ballo centrale (200 mq x 11 m di altezza), e di tutte le sale e stanze adiacenti, al loro primitivo splendore, ritrovando stucchi, decorazioni e colori settecenteschi.