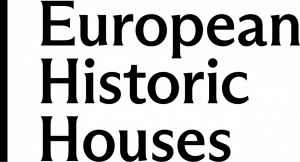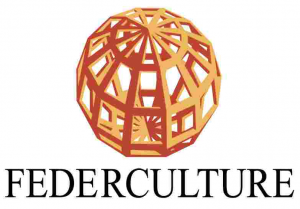XIII GIORNATA NAZIONALE - DOMENICA 21 MAGGIO 2023 - CLICCA QUI - Puglia
year 2023

Dal 21-05-2023
Descrizione
Dimora
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Fondata nel 1960, l’Accademia di Belle Arti di Lecce, dal 1970 ha sede nell’antico convento domenicano, adiacente alla chiesa di S. Giovanni Battista, comunemente detta del “Rosario”, presso Porta Rudiae, uno degli ingressi al Centro Storico della città. Il sito, tra i più belli e integri della città barocca, segna l’inizio del percorso voluto alla metà del ‘600 dal vescovo Aloisio Pappacoda a simboleggiare il potere della chiesa: da Porta Rudiae a piazza Duomo, la via è condensata da un susseguirsi di rilevanti episodi architettonici in gran parte opera di Giuseppe Zimbalo (1620? -1710), tecnico di fiducia del vescovo, come la chiesa di S. Teresa, fino alla Cattedrale barocca e al suo svettante campanile. La limpida intelaiatura della facciata del convento, ritmata da sei paraste d’ordine gigante e conclusa, alle due estremità, da eleganti portali coronati dai sovrastanti balconi, è della metà del ‘700. Attribuita da alcuni ad Emanuele Manieri, è comunque ascrivibile, se non a lui, a quella koinè borghese di cui Emanuele e il padre Mauro sono iniziatori e maestri, capaci di padroneggiare urbanisticamente il rapporto edificio – contesto con proposte architettoniche ormai lontane dalla rutilante vistosità barocca, e piuttosto tendenti ad un organico e dignitoso raccordo alla maglia strutturale della città.
Il convento dei domenicani
Attualmente sede dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, fu uno dei primi ad essere fondato in terra d’Otranto nel 1388 e dedicato a san Giovanni Battista spesso erroneamente detto anche di Giovanni d’Aymo questo perché fu quest’ultimo a finanziarne la sua costruzione. Il convento leccese fu centro di una delle più importanti comunità dell’ordine fino a diventare alla metà del seicento la più prestigiosa e prospera della famiglia domenicana. Legate alle rispettive confraternite, le comunità di quest’ordine religioso erano a lecce quattro: della natività della vergine e della visitazione della vergine (femminili), di San Giovanni e dell’Annunziata fuori le mura (maschili). Il ruolo fondamentale del loro apostolato fu intenso e decisivo, almeno sino al tempo del Vescovo Pappacoda (1640 -1670). Circa la sua configurazione originaria, sappiamo dall’infantino (Lecce sacra -1634) che la costruzione primitiva aveva volte a crociera di stile gotico, forse su modello di Santa Caterina in Galatina, con l’annesso ospedale dello Spirito Santo che era ancora visibile nel cinquecento nel progetto rifatto dall’architetto Gian Giacomo dell’Acaya. Del periodo medievale avanza ben poco, come qualche brandello di affresco e qualche fuga di archi gotici. La chiesa di San Giovanni fu ricostruita nell’ultimo quarto del Seicento anche se l’arricchimento decorativo interno era stato costante per tutto il secolo ad opera della confraternita del Rosario. Il prestigio della comunità fece si che la Chiesa fosse eletta a luogo di culto da parte di una cospicua rappresentanza di famiglie aristocratiche lupiensi: vi ebbero sepoltura i Marescalco, Antonio de Ferrariis “Galateo”, i Montefuscoli, i Della Ratta e i Paladini. E tutto fu poi cancellato dalla ricostruzione del 1690, mentre il convento fu rifatto un decennio dopo grazie al progetto dell’architetto Giuseppe Zimbalo (1620-1710), il vero maestro del barocco leccese, tecnico fiduciario di Mons. Pappacoda, che diventato famoso con la costruzione della cattedrale, aveva di fatto rinnovato il volto urbanistico di Lecce. Il convento fu ricostruito ad opera di Emanuele Manieri e i lavori si conclusero verso il 1750. Emanuele Manieri era figlio di Mauro Manieri, l’artefice Secentesco di numerosi altari interni alla chiesa di San Giovanni Battista. L’opera del Manieri è all’insegna della razionalizzazione con una facciata sobria divisa da sei paraste d’ordine gigante con alle estremità i due ingressi al cortile, proteso tra la chiesa e la Porta Rudiae. Nel perfetto quadrato del chiostro, il quadriportico a pilastri rende funzioinali e autonome le varie parti del cortile. Esse si innestano co le sezioni del convento elevao a sua volta su due piani. Nel periodo murattiano la chiesa e il convento furono chiusi (1807) riaperti nel 1821 dopo un periodo di utilizzo quale manifattura tabacchi (1812), il celebre tabacco leccese esportato anche in Francia come ricorda il Foscarini.
Contatti