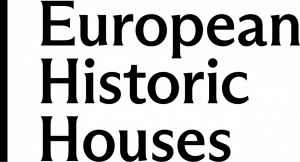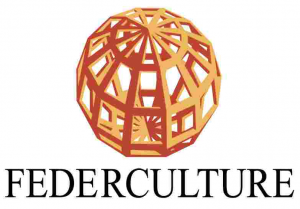XIII GIORNATA NAZIONALE - DOMENICA 21 MAGGIO 2023 - CLICCA QUI - Lombardia
year 2023

Dal 21-05-2023
Descrizione
In occasione della Giornata Nazionale sarà possibile visitare il cortile con ingresso libero e gratuito dalle h10 alle h18. Sarà inoltre possibile partecipare ad attività collaterali (tour guidato con prenotazione obbligatoria), trovate tutte le informazioni e la possibilità di prenotazione al link: https://shop.targetturismo.com/it/home/492-1020-brescia-tesori-delle-quadre-di-san-faustino-21-maggio-2023.html#/444-turni-visita_guidata_ore_1000
Dimora: Palazzo Soncini
Costruito a partire dalla seconda metà del 1700 per volontà del nobile Virgilio Soncini, il palazzo fu completato nel 1776 dal figlio Antonio, socio fondatore dell’Accademia di Fisica sperimentale e Storia naturale presso la Biblioteca Queriniana. Sulla base di analisi strutturali e decorative, il palazzo è stato attribuito all’architetto Antonio Marchetti (Lechi 1977, p. 362), togliendolo a Bernardo Carboni, a cui era stato in origine ricondotto (Fè d’Ostiani 1927, p. 54). La facciata, considerata come la più barocca dell’intera città di Brescia (Lechi 1977, p. 363), appare originale per le cornici delle tre fasce di finestre: il disegno capriccioso e ricercato, in bilico fra barocco e rococò, presenta panoplie e varie decorazioni in stucco, terminante in alto con un cornicione piuttosto semplice. Il portale barocchetto, disposto non perfettamente al centro della facciata, è sovrastato da un balcone arcuato, sorretto da due grandi mensoloni. Si tratta di un edificio a due piani che adotta il canonico schema a U, costituito cioè da un corpo di fabbrica centrale e da due ali laterali; a piano terra, l’ala destra è occupata da un porticato composto da nove volte a crociera piuttosto basse, appoggiate, in maniera alquanto insolita, sia a colonnine che a pilastri, dando all’ambiente un aspetto di solennità, mentre quella sinistra ospita un giardino scoperto con una fontana caratterizzata da un catino a conchiglia rovesciata in cui compaiono due delfini con la coda intrecciata e terminante in alto con il busto di Diana, attribuita al disegnatore Vincenzo Berenzi alla fine del Settecento. Superate le ultime campate sorrette da pilastri, si raggiunge lo scalone che permette l’accesso al piano nobile. Dal corpo centrale costituito dalla galleria, due sale con soffitti con quadrature monocrome e da un’alcova che si affacciano sulla strada, si può proseguire verso est giungendo a tre sale terminanti con una loggia cinquecentesca a tre archi con un portico sottostante; oppure verso ovest dove, invece, si susseguono una serie di sale alquanto caratteristiche, come la Sala dei Medaglioni e la saletta ottogonale, in parte rovinate dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Il palazzo fu decorato all'interno dai più rinomati pittori del tempo: lo scalone da Pietro Scalvini; una sala neoclassica da Giuseppe Teosa; una saletta ottagonale da Giuseppe Manfredini. Lo scalone d’onore a pianta quadrata, formato da tre rampe di scale affiancate da balaustre con colonnine in pietra, è collocato all’estremità del corpo di fabbrica principale e si distingue per la presenza al livello superiore di due pianerottoli distinti, non collegati tra loro: il primo è posto all’estremità dell’ultima rampa di scale e consente l’accesso alla galleria affacciata verso la corte interna; il secondo è raggiungibile dall’adiacente sala posta all’inizio dell’enfilade di stanze rivolte verso la strada. La balaustra in pietra che ne delimita l’affaccio sullo scalone è ornata da quattro statue di amorini. Le pareti del vano sono arricchite dagli affreschi realizzati da Pietro Scalvini. All’interno di una partitura architettonica costituita da lesene con fusto scanalato e capitello corinzio, l’artista crea una sorta di «teatro di posa della nobiltà bresciana settecentesca ritratta nella ritualità quotidiana» (Giornate di studi su Pietro Scalvini, 2008, p. 11): i personaggi vengono raffigurati all’interno di logge con parapetti in pietra identici alle balaustre delle scale, accentuando il gioco tra realtà e finzione. La prima scena ritrae due donne sedute su un divano e un bambino in piedi sul corrimano, mentre nella parete opposta un gentiluomo in velada viola e una dama elegantemente accomodata su un divano rococò conversano tranquillamente, serviti da un domestico che porge un vassoio con una tazza fumante di caffè o cioccolata; il terzo episodio, inserito tra le finestre del pianerottolo rivolto verso la strada, illustra una coppia che conversa ai piedi di una statua di Minerva. Il livello superiore delle pareti è occupato da una seconda serie di finestre con balconcini rococò, due reali aperte sul cortile e sei popolate da musici e danzatrici che vanno ad allietare la scena, accompagnando idealmente la salita e la discesa degli ospiti e degli abitanti del palazzo; ben rappresentati sono gli strumenti musicali, quali timpani, flauti, silofoni, piatti e corni ma anche oboi e triangoli. L’opera è l’esempio più celebre di pittura profana dello Scalvini, che lascia la sua firma sul collare di un cagnolino («P. SCALVINI»); egli appare aggiornato sulle imprese decorative dell’area veneta e, in particolare, sugli affreschi realizzati pochi anni prima da Francesco Zugno nella Sala dell’Accademia degli Erranti, oggi Ridotto del Teatro Grande di Brescia, e da Carlo Innocenzo Carloni nella villa Lechi a Montirone. Il soffitto, separato da una modanatura a dentelli e decorato con fasce di stucco e rosoni, presenta al centro un dipinto murale raffigurante Ercole fra l’Eternità e la Fama: tema molto caro alla tradizione pittorica della città (Ercole il fondatore, 2001), ma anche alla famiglia stessa, in quanto due membri, un chierico morto nel 1721 e suo nipote gesuita e compositore di corone poetiche, erano omonimi dell’eroe. Ercole, raffigurato al centro su una nuvola, simboleggia la Virtù Eroica e rappresenta la ragione che sottomette le passioni; oltre alla clava e al leone, attributi tradizionali, la figura mitologica reca fra le mani tre pomi portati dagli orti esperidi allusivi alle virtù della temperanza, della moderazione e del disprezzo dei piaceri. Alla destra compare l’Eternità, raffigurata alatae rivolta verso Ercole, mentre regge fra le mani l’uroboro. Sulla sinistra compare la Fama accompagnata da alcuni putti che suonano la tromba. A sud dello scalone si accede alla grande galleria che fungeva da salone da ballo: si tratta di una sala rettangolare, le cui pareti sono ornate da festoni e panoplie in stucco bianco, realizzati tra il 1770 e il 1772 da Cristoforo Negri. Tra gli elementi delle composizioni in stucco compare anche lo stemma della famiglia Soncini, costituito da un corvo posto su un dardo, recante un anello in bocca. La volta è invece opera del pittore bresciano Pietro Scalvini, il quale distribuisce lungo il perimetro gruppi di figure rappresentanti le arti e le scienze: la Scultura è interpretata da uno scalpellino intento a lavorare ad una statua; la Musica da un gruppo di musicisti; la Filosofia da pensatori e putti con la testa avvolta in un velo; il Valore militare da un uomo armato con dei prigionieri ai suoi piedi; la Pittura da un artista impegnato a ritrarre una donna e da due figure che stanno ammirando un ritratto ovale; seguono la Geografia e l’Astronomia. Agli angoli, inoltre, si conservano quattro medaglioni in monocromo, dove sul cuore di un’aquila bicipite, compaiono le Virtù Cardinali. Di mano scalviniana è ancora l’affresco realizzato al centro della volta, ossia Il carro di Apollo che caccia la Notte; in un cielo luminoso solcato da nubi rosate che fuoriescono con controllata pacatezza dalla cornice architettonica compare il dio del Sole sul suo carro trainato da due cavalli bianchi mentre mette in fuga la Notte, rappresentata allegoricamente da una giovane donna che, posta nell’ombra, si copre gli occhi con una mano. Nella parte inferiore compaiono, inoltre, un gruppetto di putti mentre mostrano il cartiglio «Cadit aemula lucis», a confermare la scena. Questi affreschi, annoverati tra i capolavori dell’artista, mostrano chiaramente la sua pittura solida, disegnata, concreta e spiritosa; il pittore bresciano è infatti ritenuto uno dei decoratori più dotati di gusto e fantasia in ambito lombardo, soprattutto per la bellezza fragile e la delicata giovinezza delle figure, il disegno leggero, i colori chiari e un certo amore per il chiaroscuro.
Indirizzo
Via Soncin Rotto, 1
25100 Brescia BS